
 |
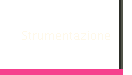 |
 |
 |
 |








Rumore e suono
Il rumore viene comunemente identificato come un “suono non desiderato” o come una “sensazione uditiva sgradevole e fastidiosa o intollerabile”, definizioni queste, apparentemente imprecise, ma in realtà perfettamente rispondenti, in quanto il rumore ha, dal punto di vista fisico, caratteristiche che si sovrappongono e spesso si identificano con quelle del suono, al punto che un suono, gradevole per alcuni, può essere percepito da altri come un rumore fastidioso, né, d’altra parte, sono propri del rumore la disarmonia (intesa come mancanza di periodicità, o come improvvise deformazioni dello schema primitivo delle onde sonore), o l’elevato livello energetico, o l’insorgenza improvvisa, o ancora l’ampiezza e la rapidità delle variazioni di pressione sonora e di frequenza dell’onda incidente, tanto che restano a caratterizzare il rumore la sua particolare sgradevolezza e la sua difficile sopportabilità. E’ il carattere di disturbo e di sofferenza che accompagnando certi fenomeni sonori, li qualifica come rumori.
In fisica è piuttosto difficile distinguere fra suoni e rumori, in quanto gli uni e gli altri posseggono caratteristiche pressoché sovrapponibili. Sia un suono che un rumore infatti, possono essere descritti come un fenomeno di periodico prodotto dall’apporto di energia meccanica che fa entrare in vibrazione un mezzo (generalmente, ma non necessariamente si tratta dell’aria).
Un suono, nella quasi totalità dei casi, deve essere più precisamente classificato come un fenomeno periodico complesso, costituito dalla somma di differenti fenomeni periodici semplici, ognuno dei quali è caratterizzato da una ben determinata frequenza di oscillazione.
Le più importanti grandezze fisiche che caratterizzano il suono sono costituite dalla ampiezza e dalla frequenza del fenomeno oscillatorio. Quando il fenomeno oscillatorio ha carattere periodico ma le oscillazioni si producono in forma irregolare od aleatoria per l’effetto della combinazione di un gran numero di componenti che non risultino armonicamente correlate fra loro, allora si determina la genesi di un fenomeno acustico che ordinariamente viene definito “rumore” (vedi fig. 1). Mentre la ampiezza caratterizza il livello della sensazione uditiva, la frequenza f=1/T caratterizza la tonalità del suono percepito (le basse frequenze sono proprie dei toni gravi mentre le alte sono proprie dei toni acuti). vedi fig. 2.
Fig. 1
Fig. 2
Lo Studio Tecnico “acusticadb” del per. ind. Luigi Pelino si prefigge di studiare ed analizzare i fenomeni acustici al fine di proporre soluzioni nel campo del acustica ambientale, architettonico e del lavoro, attraverso le seguenti metodiche:
- Analizzare il fenomeno acustico in esame mediante appropriate tecniche di misurazione;
- Creazione di modello acustico utilizzando software di calcolo acustico;
- Simulazione di scenari acustici, mediante calcolo predittivo, in fase di progettazione;
- Progettare sistemi di mitigazione ed isolamento del fenomeno acustico in esame;
- Verificare in opera l’efficacia del nuovo sistema acustico di isolamento o di quelli preesistenti.


Articolo del Giorno
Milano 12 giu- (Adnkronos) - Si completa la classificazione acustica degli edifici grazie ad una nuova norma Uni. Già dal 2010, con la pubblicazione della norma Uni 11367 'Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera', Uni aveva messo a disposizione degli operatori del settore costruzioni e nell'interesse degli acquirenti di case uno strumento ai fini della classificazione acustica degli edifici. La classificazione acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine dell'opera, consente infatti di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio da possibili successive contestazioni.
In questi due anni di applicazione della Uni 11367 si sono riscontrate alcune difficoltà nel valutare i requisiti acustici degli edifici con caratteristiche 'non seriali'. A differenza degli 'edifici seriali' strutturati in modo tale che ci siano elementi che si ripetono uguali secondo schemi che dipendono da caratteristiche distributive, organizzative e funzionali (ad esempio condomini, alberghi, ospedali, scuole, ed edifici assimilabili) che rendono quindi più semplice, meno costosa e più attendibile la classificazione acustica, gli edifici 'non seriali' presentano unità immobiliari aventi elementi costruttivi anche molto diversi tra loro e quindi con maggiori problemi di classificazione.
Per questo motivo Uni ha pubblicato proprio in questi giorni la norma, la Uni 11444 'Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Linee guida per la selezione delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche non seriali'. La nuova norma Uni 11444, spiega Giuseppe Elia, presidente della commissione 'Acustica e vibrazioni' dell'Uni, "offre un approccio semplificato attraverso la scelta di alcune unità immobiliari dell'edificio, più critiche sotto il profilo delle prestazioni acustiche di suoi elementi tecnici, nelle quali effettuare le misurazioni previste dalla Uni 11367. In tal modo il responsabile della classificazione acustica può utilizzare i risultati di tale valutazione per classificare le restanti unità immobiliari dell'edificio'.
Sulla base delle indicazioni contenute nella nuova Uni 11444 il tecnico che esegue le prove stabilisce la casistica e il numero delle unità immobiliari da sottoporre a misurazione. Per la selezione delle unità immobiliari maggiormente critiche, devono essere prese in considerazione tutte le criticità degli elementi edilizi e degli impianti all'interno dell'edificio.
La nuova Uni 11444 considera infatti gli elementi più problematici per l'isolamento acustico di facciata (ad esempio i serramenti), delle partizioni interne verticali (pareti divisorie) e orizzontali (pavimenti), per il livello di rumore da calpestio e per il rumore degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo. La norma Uni 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale 'di base' sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe.
Ai lavori di elaborazione di tale norma hanno partecipato, tra gli altri, il ministero dell'Ambiente, l'Ispra, le associazioni della filiera delle costruzioni quali Ance, Anit e Cna, la Regione Lombardia, le Università, le Associazioni dei tecnici acustici, i laboratori di prova e i fabbricanti di materiale fono isolante.

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
per. ind. Luigi Pelino, Viale Bonomi, 2 - 03043 Cassino (FR) - Partita IVA:02690300609
Cell. 3475984400; e-mail: info@acusticadb.com
Iscritto all'Albo Professionale del Collegio dei Periti Industriali di Frosinone al n.ro 423 dal 25/02/2011
Iscrizione presso la Lista Regionale del Lazio n. 929, Det. B0941 del 16/03/2009